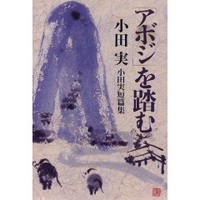STORIE di GUERRA dal GIAPPONE
«Ogni incontro è irripetibile». In giapponese si dice «Ichigo Ichie»: è il titolo di un singolare e bel romanzo di Makoto Oda (Traduzione di Manuela Suriano, a cura del Centro di documentazione “Semi sotto la neve”, DeriveApprodi) una storia personale, di amore e di politica, sulla guerra e sulla pace. Il libro è un ponte tra Giappone e Stati Uniti, passando per il Vietnam. I più anziani di noi ritrovano qui i dolori, le passioni, di quella guerra che ci formò alle scelte storiche, da giovani. L’Europa è soltanto sullo sfondo, emerge un po’ la Francia con la sua contraddizione tra colonialismo e civiltà, la stessa contraddizione dell’America (così sono chiamati quasi sempre, impropriamente, gli Stati Uniti) tra democrazia, dominio e guerra. La critica della potenza e violenza americana è condotta con amore per l’America e i suoi valori: specialmente la «coabitazione tra valori diversi» (p. 247) (ma è del tutto vero?). Però c’è anche la tristezza per l’assenza di «popoli sani». L’Autore non nasconde nulla del Giappone: il potere divinizzato, il militarismo, il cinismo dell’imperatore a danno del popolo negli ultimi giorni di guerra (pp. 180-182).
Una piccola folla di personaggi, di «semplici cittadini» si incontrano, riflettono in lunghe conversazioni, ricordano, viaggiano, conoscono e mettono in relazione popoli e culture diverse. Cioè, fanno opera concreta di pace. L’umanità è una sola, gli stessi sentimenti sono comuni a tutti. Le lingue si traducono e si imparano. Gli altri paesi si visitano e si amano. I volti si guardano e si riconoscono. La bellezza coi suoi misteri si è incarnata nei monumenti di Nara, di Atene, di Chartres (pp. 151, 191). L’etica seria e umana del matrimonio non appartiene ad una sola civiltà o religione (da pp. 194), così come i riti funebri (p. 200).
Il tempo del racconto è recente, intorno al 2003, porta le conseguenze dell’11 settembre di New York, guarda avanti, fino ad oggi: ma compaiono appena le guerre anti-terrorismo e non si prevede quella ripresa di speranza apparsa con Obama. Sempre è presente il passato che ha segnato tutti. Fatti storici e precisi dati quantitativi e qualitativi sono offerti al lettore attraverso questi vivi personaggi.
Filo conduttore è una bella e «leale» storia d’amore, i cui protagonisti, già scomparsi, parlano lungamente nelle lettere e nei ricordi e rivivono nei discendenti. È un libro di storia, narrata sulla trama di queste relazioni personali. A volte i dialoghi sono un semplice supporto per narrare la storia. Una storia fatta di popoli e di generazioni, che guardano i poteri “alti” dal basso della vita reale e delle sofferenze.
Accanto all’amore c’è la guerra, dalla guerra sino-giapponese alla seconda mondiale (bella persona il veterano Al, ora pacifista statunitense), al Vietnam (guerra di liberazione paragonata dai pacifisti Usa a quella americana del 1776). Ci sono i massacri, da Nanchino, a Osaka, agli stupri di Berlino, a Song My (che noi in Italia conoscevamo come My Lai), e i defolianti, che continuano a deformare i neonati (finora il governo americano «non ha presentato scuse né fornito risarcimenti», p. 349). La guerra è dolore. Finisce la guerra, ma non il dolore. «La democrazia lanciava bombe atomiche e il socialismo stuprava le donne» (p. 164).
Da notare che l’Autore giapponese non “usa” Hiroshima e Nagasaki, come altri fanno delle proprie tragedie quasi arrogandosi in esclusiva il dolore e l’offesa della violenza. Semmai Oda non risparmia la descrizione delle violenze giapponesi.
Cosa accade in un uomo mandato ad uccidere altri uomini, a bombardare città e villaggi che vede solo da lontano? Un virus distruttivo lo penetra. Fin quando l’esercito lo conduce e lo usa, lui non se ne accorge, ma quando si trova da solo davanti alla guerra, l’aggressore diventa vittima lui stesso (p. 174) di quel meccanismo mortifero, che può spingerlo anche fino al suicidio. Parole di Curtis LeMay, comandante dell’aviazione americana lanciata sul Giappone: «Se avessimo perso, sarei stato processato come criminale di guerra. Fortunatamente eravamo noi i vincitori». «Tutte le guerre sono immorali. Se si pensa alla morale non si può vincere». Lo stesso LeMay ricevette nel 1964 dall’imperatore la massima onorificenza giapponese per il contributo alla ricostituzione delle forze armate. È lui quello che nel 1965 disse: «Riporteremo il Vietnam all’età della pietra» (pp.57-58). Churchill: «Ci sono momenti in cui un intero popolo impazzisce» (p. 88).
Ma l’aggressore-vittima si può curarlo, ed egli può reagire, a volte. Questo è un motivo di pietà verso tutti, diversamente vittime. Però il meccanismo va fermato. Come?
Un protagonista è il movimento giapponese contro la guerra, visto non tanto nelle manifestazioni pubbliche (assistiamo anche a quelle in Usa), quanto nell’azione clandestina di accoglienza e assistenza prestata dai giapponesi ai disertori americani dalla guerra in Vietnam, drogati, e col cuore «inaridito» (p. 110). Ma il cuore più arido era quello del loro paese (p. 120). Confesso che non conoscevo questo fenomeno dei disertori accolti e assistiti in Giappone. Apprendo che l’età media dei soldati americani in Vietnam era di 19,2 anni (p.101). Si arruolavano per mancanza di lavoro (p.121). La repressione interna all’esercito Usa era estrema (pp. 118-119)
Si può osservare che lo spirito di questo movimento di rifiuto dell’uccidere come del venire uccisi non procede, come fa la cultura gandhiana, nel costruire metodi di vera lotta di liberazione libera dall’uso della violenza, con mezzi di forza nonviolenta. Però è chiaro che pace e pacifismo si distinguono: la pace è quiete, il pacifismo è forza della quiete (p. 165)
Dunque, quale politica? Quale pacifismo? Esistono due vie, teorizzate da Sun Yat-sen: la via egemonica e la via “regale” (p. 209). Questa seconda è l’arte del regnare con giustizia (p. 364). L’Occidente ha praticato la prima, l’Oriente conosceva la seconda via, ma sta imitando l’Occidente sulla prima. Così, due tipi di forze ci sono: la forza statica, propria dell’Oriente, e la forza dinamica, propria dell’Occidente (p. 158): il Vietnam ha vinto sulla forza dinamica di Francia e Usa con la forza statica, che è la forza del popolo, non degli eserciti. Noi la chiamiamo difesa popolare democratica, che sarebbe ancora più forte se fosse decisamente nonviolenta.
Dopo la sua tragica esperienza, il Giappone ha scritto nella Costituzione il ripudio della guerra e dell’esercito (pp. 165-166). Aveva capito che «la democrazia si lega in maniera inscindibile al pacifismo» (p. 162). Ma la politica governativa non segue questo principio.
Obiezione abituale al pacifismo: non fu forse la guerra contro il nazismo giusta e necessaria? (p. 184). La risposta, nel romanzo storico di Oda (pp. 184 e ss.), è l'uguaglianza tra i crimini commessi da Hitler e quelli dei combattenti contro di lui. Gandhi lo prediceva agli inglesi esattamente il 18 maggio e il 7 luglio 1940 (si veda in Teoria e pratica della nonviolenza). Tanto che esiste una tesi che chiede «Ha vinto Hitler?» (raccolta, ancora in modo incompleto, nel mio libro Dov'è la vittoria?). Giuliano Pontara in L'antibarbarie mostra il nocciolo del nazismo oggi largamente presente nella politica, e ripropone gli antidoti gandhiani. Il romanzo di Oda non considera abbastanza la prevenzione che era possibile, come Gandhi, quasi solo, aveva visto. Anche una guerra che appare necessaria, con giuste ragioni, diventa fatalmente ingiusta. Bisogna vedere per tempo che non è fatalmente necessaria, perciò costruire alternative nonviolente nella conduzione dei conflitti.
La pace non è la conservazione dello status quo (pax romana), il cui mantenimento implica la guerra. I cambiamenti sono necessari, ma in modo nonviolento. I palestinesi sbagliano ad usare gli attacchi suicidi, come sbagliò il Giappone. Questi metodi non hanno successo (pp. 240-241).
C’è ammirazione per Sun Yat-sen (da pp. 206), il padre della rivoluzione cinese, che voleva realizzare il meglio e non il peggio delle rivoluzioni francese e russa, progetto tradito dai rivoluzionari successivi.
Nel lungo racconto c’è anche preghiera (cioè riflessione, meditazione), c’è cucina tipica in abbondanza, e c’è poesia. Si è condotti per mano a visitare le città, quasi vedendole. Una lunga sezione (da pp. 251 alla fine) è dedicata al Vietnam, luogo d’incontro di tutti i protagonisti, con vivida rievocazione della sua storia, con dati umani e quantitativi sulla guerra e sui massacri. I connazionali odierni degli autori dei vari massacri, si chiedono l’un l’altro: «Tu che cosa avresti fatto?». Un silenzio pensoso è la risposta seria.
In Vietnam rivediamo immagini presenti nella nostra memoria, come il monaco immolatosi (non suicida!) nel fuoco. Mi aspettavo di vedere descritta anche la foto della bambina nuda che fugge piangendo terrorizzata dal villaggio in fiamme, immagine di tutta l’umanità offesa da tutte le guerre.
C’è molta ammirazione anche per Ho Chi Minh, di cui si loda la risolutezza insieme alla saggezza e la sensibilità umana, trasparente nelle sue poesie, che Jane Fonda consigliò a Nixon di leggere. Lui non le lesse e riprese i grandi bombardamenti sulle città. La città di Hanoi oggi racconta visivamente tutto questo ai protagonisti americani, giapponesi, coreani. La guerra uccide, chi fa la guerra uccide, ma si capisce la guerra solo dal punto di vista di chi viene ucciso (da pp. 340).